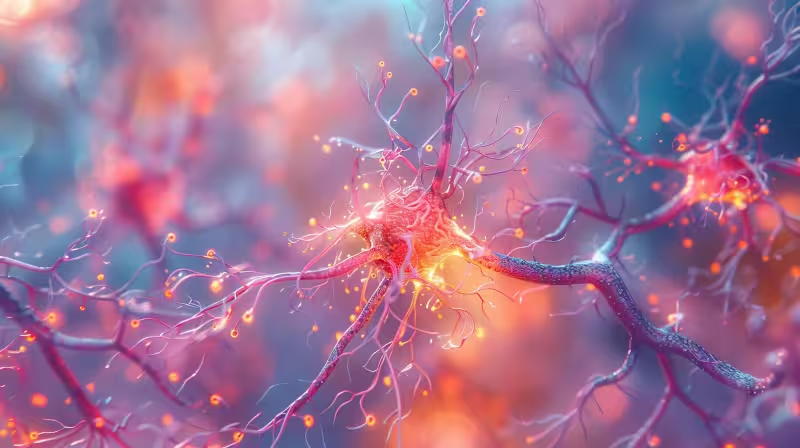
Tutto sulla sclerosi multipla: come riconoscerla, le cause ambientali e genetiche scoperte grazie alla ricerca scientifica, i trattamenti per rallentarne il decorso.
È la più comune malattia neurologica potenzialmente invalidante tipica dell’età giovanile.
Colpisce circa 2,9 milioni di persone nel mondo, circa un milione negli Stati Uniti e tra 68.000 e 75.000 soggetti in Italia. Soprattutto donne. Soprattutto tra i 20 e i 40 anni.
Spesso si sente dire che della sclerosi multipla (SM) non si conoscono ancora le cause, tuttavia questo non è del tutto vero. È ormai chiaro che fattori come esposizione alla luce del sole e vitamina D, inquinamento, infezioni virali, obesità infantile, combinati con la genetica di un individuo, svolgono un ruolo importante nella manifestazione e nel decorso della patologia.
La sclerosi multipla non è considerata una patologia mortale. Oggi, grazie ai progressi della ricerca, sono aumentate le opzioni terapeutiche disponibili, permettendo di rallentarne il decorso e migliorare significativamente la qualità della vita delle persone che ne soffrono.
In questo articolo approfondiremo la natura della sclerosi multipla, esplorandone le cause, i sintomi, le modalità diagnostiche e i più recenti approcci terapeutici.

La Sclerosi Multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il Sistema Nervoso Centrale, ossia cervello e midollo spinale. È caratterizzata da una progressiva degenerazione della mielina, la sostanza grassa che protegge le cellule nervose che hanno il compito di trasmettere i segnali dal sistema nervoso centrale agli organi e ai muscoli del corpo.
Il nome sclerosi multipla deriva dalle cicatrici (sclerosi, meglio note come “placche attive o lesioni) che si formano nelle diverse aree (da qui “multipla”) in cui la mielina subisce un danno. Macchie bianche che la malattia, come un pennello gocciolante, lascia cadere nella guaina isolante del midollo spinale e del cervello. A volte piccole, a volte grandi, a volte sfumate. In base a come si spandono, disegnano la vita della patologia. Segni invisibili all'occhio, ma ben presenti alle onde radio delle risonanze.
Non esiste una sclerosi uguale a un’altra: questa patologia può manifestarsi con sintomi lievi e sfumati o con sintomi acuti e improvvisi. Può progredire lentamente nel tempo o alternare fasi di peggioramento a fasi di stabilizzazione.
Questa variabilità clinica ha portato alla classificazione della malattia in quattro principali forme, ognuna con caratteristiche distinte, decorso clinico peculiare e risposte terapeutiche differenti. Comprendere queste varianti non è solo un esercizio teorico, ma un passo fondamentale verso una medicina personalizzata e più efficace.
Per poter meglio descrivere la situazione di una persona affetta da sclerosi, e capire come si comporta la malattia nella terminologia medica sono stati introdotti due nuovi “descrittori”:
In sostanza, anziché dire solo “SM-RR”, ora un medico ad esempio può parlare di:

Vaghi sintomi di demielinizzazione nel cervello iniziano a volte molto prima che venga diagnosticata la malattia. Spesso sono difficili da riconoscere, perché possono essere confusi con disturbi più lievi o temporanei.
Tuttavia, ci sono alcuni segnali caratteristici che, se persistenti o ricorrenti, possono indicare la presenza della sclerosi multipla:

Parallelamente all’accumularsi dei danni al sistema nervoso centrale, i movimenti possono diventare sempre più irregolari e scattosi. I muscoli si contraggono involontariamente, causando a volte crampi dolorosi. Questi problemi possono rendere estremamente difficoltosa o impossibile la deambulazione, in alcuni casi si è costretti alla sedia a rotelle. Il rischio è quello di diventare completamente o parzialmente paralizzati.
La perdita della capacità di camminare aumenta inoltre il rischio di osteoporosi (riduzione della densità ossea). L’eloquio può diventare lento, impreciso e caratterizzato da pause frequenti.
Alcuni individui sperimentano difficoltà nel controllare le proprie emozioni, manifestando risate o pianti incontrollabili. È frequente la comparsa di depressione, così come lievi problemi cognitivi, come difficoltà di concentrazione, attenzione e memoria.
Molto comune è il coinvolgimento dei nervi che regolano le funzioni della vescica e dell’intestino. Tra i disturbi urinari più frequenti vi sono:
In casi rari, quando la malattia raggiunge stadi molto avanzati, può manifestarsi anche una forma di demenza.
Infine, se gli episodi di recidiva diventano sempre più frequenti, la disabilità può progredire fino a diventare permanente, limitando significativamente l’autonomia e la qualità di vita della persona.
La diagnosi della sclerosi multipla avviene attraverso una valutazione approfondita da parte di un neurologo, che include l’analisi della storia clinica del paziente, un esame neurologico dettagliato e specifici test diagnostici. Tra questi, particolare importanza hanno la risonanza magnetica (RM), che evidenzia le lesioni tipiche a carico del sistema nervoso centrale, e l’esame del liquido cefalorachidiano (liquor), ottenuto tramite puntura lombare, che può rivelare i segni di infiammazione caratteristici della malattia. Talvolta possono essere eseguiti anche test sui potenziali evocati, esami utili a misurare la velocità con cui il cervello risponde agli stimoli. La diagnosi definitiva richiede di norma la presenza di più episodi sintomatici e lesioni disseminate nello spazio (regioni differenti del sistema nervoso centrale) e nel tempo (che compaiono in momenti differenti).
La lesione cerebrale che causa questa patologia neurologica non può essere guarita ma, con una diagnosi precoce si può fermare lo sviluppo della malattia ed evitare l'insorgere delle disabilità motorie o cognitive.
Le cause precise della sclerosi multipla rimangono ancora in parte ignote, ma le ricerche scientifiche ci offrono oggi alcune piste convincenti. Sembra che la malattia derivi da una combinazione di fattori genetici e ambientali che innescano una risposta anomala del sistema immunitario, il quale, anziché proteggere l'organismo, attacca per errore la mielina.
Non esiste però una sola causa certa: è molto probabile che la sclerosi multipla nasca dall'interazione complessa di diversi fattori, ognuno con un ruolo ancora da definire completamente.
La sclerosi multipla colpisce molto più spesso le donne rispetto agli uomini, ma non è sempre stato così. Le prime casistiche del Novecento mostravano un equilibrio quasi perfetto tra i sessi. Col passare del tempo, però, il divario è aumentato: attualmente, nei paesi sviluppati, si registrano circa tre casi nelle donne per ogni uomo colpito dalla malattia. Il motivo? Uno dei fattori che potrebbe spiegare questo squilibrio crescente è il fumo di sigaretta, riconosciuto come un importante fattore di rischio per la SM, con un incremento del rischio individuale stimato attorno al 50%. Si calcola che il fumo possa essere responsabile di fino al 40% dell’aumento dei casi nelle donne. Questo dato è particolarmente interessante se si considera che, prima della Seconda guerra mondiale, quasi nessuna donna fumava, mentre il boom del tabagismo femminile nel dopoguerra ha coinciso con l’aumento dell’incidenza di SM nella popolazione femminile.
Inoltre, è stato osservato che alcune sostanze chimiche, come i solventi organici e il fumo di sigaretta, sono legati alla SM. Questo non vale invece per altre forme di tabacco, come quello da masticare o da fiuto.
Sebbene non si tratti di una patologia direttamente ereditaria, avere un parente di primo grado, come un genitore o un fratello, affetto dalla malattia, aumenterebbe il rischio di svilupparla.
Ci sono aree del mondo dove la sclerosi multipla è più frequente. In particolare, l’incidenza di questa patologia aumenta a mano a mano che ci si allontana dall’equatore. L’ipotesi è che questa correlazione dipenda dall’assenza di esposizione alla luce del sole e alla vitamina D ed, effettivamente, sono diversi gli studi che confermano che bassi livelli di questa vitamina rappresentino un fattore di rischio per la sclerosi. Tuttavia non è ancora del tutto chiaro se un'integrazione preventiva di vitamina D possa effettivamente ridurre il rischio di sviluppare la malattia, aspetto ancora oggetto di studi scientifici.
Anche l’inquinamento rappresenta un fattore di rischio. Uno studio italiano pubblicato sulla rivista Neurochemistry International, ha dimostrato che l'esposizione cronica ad alti livelli di polveri sottili - il famoso PM (particulate matter) - pare essere anche associata a una prevalenza della sclerosi multipla in alcune popolazioni.
Sono stati identificati diversi virus e batteri che potrebbero essere collegati all’insorgere della malattia, come ad esempio il virus Epstein-Barr (responsabile della mononucleosi). Secondo gli studi l'infezione sintomatica da EBV raddoppia le probabilità di contrarre la SM.
L'obesità durante l'infanzia e l'adolescenza è stata identificata come un significativo fattore di rischio per lo sviluppo della sclerosi multipla (SM). Gli studi hanno evidenziato che un indice di massa corporea (IMC) elevato in età giovanile è associato a un aumento del rischio di sviluppare la malattia.
Dalla sclerosi multipla non si guarisce, ma con la sclerosi si può convivere. La strategia terapeutica mira principalmente a rallentare l'evoluzione della malattia, ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita delle persone.
Il trattamento della sclerosi multipla (SM) si articola in due grandi approcci: le terapie che modificano il decorso della malattia (DMTs), mirate a rallentare o prevenire la progressione della SM, e le terapie sintomatiche, volte ad alleviare i sintomi neurologici che emergono nel decorso della malattia:
Questi trattamenti funzionano tenendo "sotto controllo" il sistema immunitario ed evitando così che continui ad attaccare la mielina. L’obiettivo è quello di ridurre la disabilità a lungo termine.
Le terapie sintomatiche non modificano il decorso della Sclerosi Multipla, ma migliorano la qualità della vita dei pazienti affrontando problemi specifici, come:
Un’attenzione particolare va data alle comorbidità (es. malattie vascolari, fumo) che accelerano la progressione della malattia. Anche se le evidenze scientifiche sulle modifiche dello stile di vita sono ancora limitate, alle terapie farmacologiche è importante affiancare trattamenti riabilitativi mirati, fare attività fisica e avvalersi di un supporto psicologico, poiché l'approccio multidisciplinare rappresenta il vero segreto per convivere al meglio con questa malattia. Inoltre, una buona alimentazione, il riposo adeguato e uno stile di vita meno stressante possono diventare preziosi alleati quotidiani.
Vivere con la sclerosi multipla oggi significa imparare a convivere con una compagna di viaggio un po' imprevedibile, ma decisamente gestibile, soprattutto grazie ai progressi della ricerca fatti negli ultimi anni. Spesso questa patologia viene associata a condizioni di grave disabilità fisica, anche se in realtà la maggior parte delle persone che soffrono di SM non sviluppa una disabilità così grave da compromettere una buona qualità della vita. molte le persone che riescono a condurre una vita attiva e indipendente tra lavoro, progetti personali, vita affettiva, genitorialità, passioni.
Riguardo all'aspettativa di vita, l'Istituto Superiore di Sanità chiarisce che la sclerosi multipla, nella maggior parte dei casi, non accorcia significativamente la vita. Infatti, con le terapie attuali e una gestione attenta della propria salute, la speranza di vita è di poco inferiore – siamo attorno ai 5-10 anni - a quella della popolazione generale.
Quando la sclerosi multipla compare dopo i 50 anni, la situazione può essere un po’ diversa rispetto a chi riceve la diagnosi in età più giovane. Anche se meno frequente, l’esordio tardivo della malattia è possibile, e prende il nome di sclerosi multipla a esordio tardivo.
In questi casi, la malattia tende a seguire un decorso più lento ma continuo: spesso non ci sono le classiche ricadute alternate a fasi di miglioramento, ma piuttosto una progressione graduale dei sintomi. I primi segnali che si notano sono spesso legati al movimento, come difficoltà a camminare, rigidità muscolare o problemi di equilibrio. È meno comune, invece, che i primi sintomi siano di tipo sensoriale, come formicolii o disturbi della vista, che sono invece più tipici nelle forme giovanili.
Una delle difficoltà maggiori in questi casi è proprio arrivare alla diagnosi. Dopo i 50 anni, infatti, i sintomi della SM possono essere facilmente confusi con quelli di altre condizioni comuni dell’età, come l’artrosi, problemi circolatori o altre patologie neurologiche. Questo può portare a ritardi nella diagnosi o a percorsi diagnostici più lunghi.
Anche il modo in cui la malattia risponde ai trattamenti può cambiare. Alcuni dei farmaci più usati per rallentare la progressione della SM sono stati pensati soprattutto per forme con ricadute, più tipiche nei pazienti giovani. Per questo, nei casi ad esordio tardivo, la terapia va valutata con attenzione, considerando anche eventuali altre patologie o esigenze specifiche legate all’età.
Tutto questo non significa però che non ci siano soluzioni. Con una diagnosi corretta, una buona gestione dei sintomi e un piano terapeutico personalizzato, è possibile mantenere una buona qualità di vita anche dopo i 50 anni.
Il Laboratorio di Medical Imaging dell’Istituto Mario Negri collabora con l’unità di Neuroradiologia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, con il supporto di Roche, per instaurare un progetto di miglioramento assistenziale volto all'ottimizzazione del percorso del Paziente approfondendo lo studio della SM attraverso l’analisi quantitativa avanzata di immagini di risonanza magnetica (RM) dell’encefalo.
La RM è oggi uno strumento fondamentale non solo nella diagnosi e nel monitoraggio della SM, ma anche nella farmacosorveglianza e nella diagnosi differenziale rispetto ad altre malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale, come la neuromielite ottica e la MOGAD (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody-Associated Disease).
Questa collaborazione mira a integrare l’esperienza clinica del neuroradiologo con l’analisi quantitativa delle immagini condotta dal laboratorio. Vengono utilizzate tecniche di RM sia standard che avanzate, che consentono di studiare in dettaglio non solo la struttura, ma anche la microstruttura e la funzionalità del tessuto cerebrale. A supporto di queste analisi, vengono impiegati anche modelli di Intelligenza Artificiale, che consentono di gestire e interpretare in modo più efficiente grandi volumi di dati, migliorando la precisione e l’affidabilità dei risultati.
Attraverso queste analisi, l’obiettivo è identificare marcatori in grado di descrivere e predire la progressione della malattia, fornendo quindi ai clinici strumenti di supporto sempre più precisi, con il fine ultimo di migliorare la gestione del paziente, in particolare riguardo il trofismo del cervello, rispetto al quale c’è un gap informativo importante, dunque risulta fondamentale valutare l’atrofia cerebrale in SM sia sotto il profilo clinico con i test neuro cognitivi che sotto il profilo tecnico con la RM e con la tecnologia applicata.
Marianna Monte | Giornalista